Se la mela non fosse di nessuno
Qualche giorno fa volevo scrivere su wikipedia, sulla sua (non) probabile chiusura, sulla cultura e sulla libertà. Poi ieri è morto Steve Jobs.
Ora mi trovo a unire un po’ di pensieri su tutti questi aspetti, un po’ come i puntini di Jobs. O almeno ci provo!
Il motivo per cui avrebbe potuto chiudere wikipedia è dei più beceri e infanganti per uno stato di – presunto – diritto quale è il nostro. L’obbligo di rettifica è quasi assurdo tanto quanto l’applicazione cieca della par condicio. Serve solo a minare sempre più il valore antropologico, culturale e costituzionale della libertà di espressione. Su questo c’è veramente poco da discutere, perché di risposta al sacro e inalienabile diritto d’espressione sopra citato c’è il reato di diffamazione. Chi si sente leso si rivolge al giudice che valutera, contestualizzando l’intervento (se, cioè, proviene da persona qualsiasi, ente o istituzione, se è ironico o meno, etc..) e valutando una possibile sanzione, anche penale.
L’uno-due tutto italiano di Nonciclopedia e Wikipedia è stato tanto ridicolo quanto pericoloso. Ma noi continuiamo a dircele queste cose e fuori nulla cambia, anzi peggiora.
Ora però il provocatore, ironico e destrutturalista sono io nel porre questa domanda: ma se davvero Wikipedia avesse chiuso, sarebbe stato un così grande danno in termini di cultura?
Ripeto: cultura, e non leggi, principi, etc.. etc.. cultura, cioè quell’insieme di conoscenze, tradizioni, ragionamento, sintesi, valori, innovazioni, etc.. etc…
Faccio il cattivo e dico: no. Non sarebbe stato un danno.
Forse perché dalla mia visione agiata di prof immerso nella tecnologia vivo entrambi gli aspetti, presumendo in realtà di capire un po’ i criteri di avvicinamento a questi servizi. Lo vedo almeno in gran parte dei miei studenti e in tanti miei colleghi, scoraggiati dal chiedere la classica e ormai vetusta ricerca a casa su un tema particolare. Lo vedo, dicevo, negli studenti quando wikipedia viene presa e assunta come unica fonte di informazione, nonostante le tante premure che mettiamo nel far capire come sia una tra le tante.
Non perché manchino le voci o sia sbagliata l’idea di un’enciclopedia libera e aperta! Anzi, ben venga e spero ce ne siano di altre! E neppure perché è fatta male, perché diciamocelo: chi è che non ha almeno una volta spulciato il contenuto di una pagina prima di fare la sua lezione o di parlare di chissà qualcosa o anche solo per cercare la vita del proprio cantante preferito o di quel film. Insomma: non si critica né il fatto che ci sia né – in fondo – la sua qualità.
Su quali basi allora poggia la critica e dove voglio andare a parare?
A mio avviso abbiamo fallito l’idea che i più giovani interpretino correttamente l’ipertestualità e che il loro essere nativi tecnologici porti automaticamente a sperimentarla e a capirne il senso più profondo. La piattaforma wiki stessa si basa unicamente su parole chiave, nodi, che generano una navigazione frammentaria e orizzontale. Se la nostra era verticale (leggevamo un articolo della Treccani dal titolo all’ultima riga), abbiamo presunto che loro si muovessero orizzontalmente, che aprissero i loro frames a una molteplicità di informazioni collegate tra loro da nodi semantici, links.
Qui, a mio avviso, c’è stato il nostro fallimento.
Il tipo di approccio dei nostri giovani (e spesso anche nostro, che fingiamo di essere sempre adolescenti) è di tipo confusionario, fuzzy, senza che però in questo stato fumoso vi sia un logos che funga da elemento ermeneutico. I giovani, o gran parte di essi, hanno un approccio proto-lineare al testo, legato a pochi elementi di coerenza col contesto in cui questo testo viene prodotto. Tanto basta perché un articolo sia l’articolo, perché quel frammento di nozione sia la nozione.
Il successo di wikipedia sta nella sua copia-incollabilità. Poche parole che contestualizzano una domanda formativa (Fate una ricerca su…) e il piatto è pronto. Non vi è una selezione a valle, che maturi un senso critico interno al testo stesso.
Sulle cause di questa mia chiave di lettura del mondo ci sarebbe molto da dire. Forse l’immenso bombardamento di stimoli cognitivi e contenutistici che viene dalla TV, forse l’incapacità che la TV ha di mantenere un collegamento stabile nel suo flusso interno di trasmissioni (si pensi alla pubblicità che blocca un continuum del film e richiede la tua attenzione selettiva su molti prodotti, differenti per scopi e percezione estetica), forse la mancanza di uno stimolo educativo serio nel preservare una cultura libresca, quindi scritta, e non orale, quindi visiva. Se ne può discutere e a lungo.
Wikipedia però non è morta ma il rischio è che a venir meno possono essere le nostre capacità di creare una sintesi, di produrre cultura, di aumentare la conoscenza.
Conoscenza e innovazione, uniti al looking good, li abbiamo invero trovati nella buon anima di Steve Jobs. Al quale dobbiamo veramente essere grati perché le sue rivoluzioni digitali non sono mai state fine a se stesse ma hanno sinceramente trovato la loro usabilità nella vita quotidiana. Grafici, musicisti hanno beneficiato sin dalle origini dei prodotti Apple; i giovani hanno ritrovato il loro walkman sotto i loro polpastrelli; i manager hanno potuto portare con sé, in maniera cool, il lavoro a casa.
Steve Jobs credeva nella tecnologia, ma aveva bene a cuore che tutto parte dalla cultura. Non a caso, è stato detto in uno delle puntate di qualche talk-show di questi giorni, amava il rinascimento italiano perché questo era sintesi di cultura, innovazione delle scienze, rispetto per i canoni estetici, armonia con la natura, e così via.
Steve Jobs ci lascia anche una pesante eredità. Quella di essere, assieme alla sua Apple, il primo (secondo?) monopolista del mondo digitale. Ecco forse l’unica sua pecca e il perché non mi ha mai convinto nell’utilizzo dei suoi prodotti (oltre che per il prezzo). La cultura, l’innovazione e il progresso debbono essere liberi, ovvero modificabili e migliorabili, non solo tramite App, ma lavorando sin nel nocciolo del codice di programmazione.
Se debbo “pensare differente” ho bisogno di credere che tutti collaboriamo al progresso del mondo. Wikipedia l’ha intuito, Linux (e parzialmente Android) si sforza di metterlo in pratica con molte limitazioni, noi stessi abbiamo le nostre vite per essere portatori di conoscenza ed editor della cultura.
Ad ogni modo, restano qui le mie confuse idee che forse, e dico forse, sono riuscito ad unire puntino per puntino.
A calce del mio articolo lascio il discorso di Steve Jobs all’università di Stanford sperando che voi, e me stesso assieme a voi, siamo “affamati” e anche “folli”.
httpv://www.youtube.com/watch?v=8ogACjJcNzc


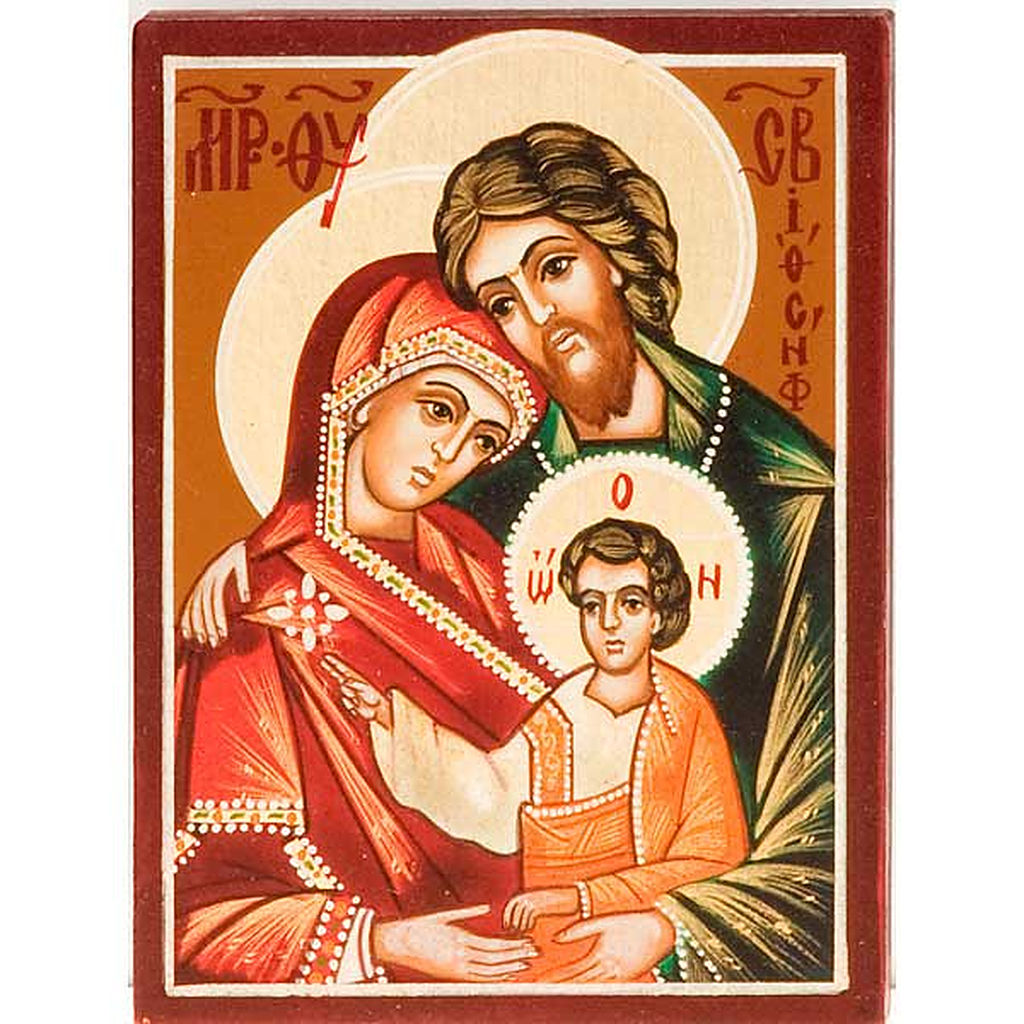
Non penso che tu abbia dimenticato che, una volta, una “ricerca” veniva fatta sulle nozioni che ci erano state impartite (da prof. preparati), su quello che il nostro cervello aveva immagazzinato e, successivamente elaborato. e non scopiazzando quello che trovavamo scritto da qualche altro. Io ricordo sempre una traduzione fatta copiando dalla Bibbia che avevo in casa e che mi valse un buon punto, ma una lavata di testa che ancora me la ricordo. Evviva quindi alle Enciclopedie multimediali, ma voi professori non dimenticate che bisogna imparare e non copiare.
Non lo trovo un commento “contrario” al mio post. In realtà è ciò che sostengo quando dico che il successo di un’enciclopedia multimediale è più suo suo essere copia-incollata che appresa. Bisognerebbe invertire un po’ la marcia, qui come altrove!
Ciao Marco!
Reagisco al post che mi piace perché fa riflettere… Quindi grazie!
A me piace l’idea che wikipedia sia una costruzione comune e “orizzontale”, come accenni anche tu.
Il problema è come si usa… però come diceva su i mezzi di comunicazione Giovanni Paolo II “i media non sono né buoni né cattivi dipende come l’uomo li utilizza”.
Qui vedo un nodo che ci chiama in causa come educatori…
Poi riguardo alla modalità (fuzzy!) di apprendimento dei giovani.
A me sembra (non è mia, ma la faccio tale) che più del logos sia il pathos ad essere centrale oggi. Proprio per questo diventa fuzzy (mi piace molto questa tua definizione e quindi te la ruberò in futuro!).
Invece (penso che ci farò un post…) il nostro sistema educativo è verticale e logico… il sistema di apprendimento delle nuove generazioniè reticolare e passionale…
L’ecologia dei media è un argomento complesso e certo mai banale ma non lo condivido sempre. McLuhan diceva che il “mezzo è il messaggio”, bypassando cioè – questa è sempre stata la mia interpretazione – il problema dell’uso corretto di un mezzo, perché se lo usi male sbagli anche la cosa che hai da dire. Il problema quindi è nell’intenzionalità, a priori dell’uso di qualsiasi utensile.
Qui c’è il (un) nodo educativo.
Riguardo poi al pathos, è interessante quanto porti nella riflessione. Ci penserò su anche io!
Grazie a te!
Un altro nodo educativo proverei ad individuarlo nel modo di intendere la relazione tra giovani-adulti-cultura-media. E’ indubbio che, se riflettiamo in profondità sulla comunicazione in genere, ci rendiamo conto di quanto essa ha spostato i meccanismi di centralità, intanto perché la comunicazione si è messa “in mezzo” (non a caso si chiamano “media”) alle relazioni fra gli uomini e ha finito per scalfire quasi tutte le altre forme di socialità che in passato legavano individui e potere, individui e società. In questo scenario, concordo con te, non abbiamo compreso fino in fondo che in qualche modo la comunicazione risentiva del virus dell’individualismo, di esagerazione delle culture dell’intrattenimento che hanno attaccanto la responsabilità di educare e l’idea stessa che l’educazione è responsabilità. Siamo stati inoltre, abbastanza inconsapevoli del fatto che la dimensione comunicativa della postmedialità, rendesse i vari ambienti “invisibili” proprio perchè pervasivi. Questo aspetto è a mio avviso determinante per leggere l’approccio dei giovani nei riguardi dei digital media, ad esempio: più si è immersi nell’ambiente e meno ci si rende conto di come l’ambiente predispone e a volte condiziona le nostre possibilità di comunicazione, relazione e cultura. Mc Luhan parlava a tal proposito di “idiota tecnologico”, ovvero di un essere talmente immerso nell’ambiente mediale (di vario genere e a vari livelli) da non rendersi conto del suo funzionamento. C’è una storiella carina ed efficace di David Foster Wallace che rende bene la situazione in cui ci troviamo: “ci sono due giovani pesci che nuotano e ad un certo punto incontriamo un pesce anziano che va nella direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: – Salve ragazzi. Com’è l’acqua? – I due pesci giovani nuotano un altro po’, poi uno guarda l’altro e fa: – Che cavolo è l’acqua?”. L’ambiente mediale nel quale ci troviamo è l’acqua e i pesci “anziani” (mc)… :D, quelli che sono cresciuti con il libro e che potremmo definire “immigrati digitali”, in alcuni casi nuotano nella direzione opposta e si muovono un po’ a fatica, ma sanno di trovarsi dentro un tipo di ambiente specifico. I giovani invece sono molto veloci e abilissimi nel “fare acrobazie”, ma essendo “nativi digitali” e avendo dunque trovato questo ambiente “già pronto”, non sanno di trovarsi dentro un tipo particolare di ambiente. Dunque da un lato più si sta dentro e meno si vede l’ambiente, ma dall’altro questo offre un’enorme opportunità in termini di alleanze intergenerazionali perchè se da un lato i giovani possiedono la capacità, la competenza, la conoscenza dei linguaggi (e quindi sanno bene come muoversi in questo ambiente), dall’altro lato non sanno dove andare e spesso, non avendo criteri di orientamento, necessitano di punti di riferimento. Dall’altra parte i “pesci anziani”, hanno invece un bagaglio di esperienze e conoscenze che possono offrire in un’ottica comunicativa autentica, ricevendo in cambio “qualche dritta”, per muoversi in questo ambiente così complesso.
Il problema non sta dunque, come ben evidenziato da te e da Andrea, in wikipedia, nella tv, o nei vari strumenti e ambienti mediali, che di per sé non hanno un fine dichiaratamente educativo/formativo (anche se a volte si sono trovati ad assumerlo nei casi in cui le tradizionali agenzie formative e gli adulti in genere, hanno “abdicato” tale ruolo), ma sta in “chi” e “come”, “media i media”. I giovani possono essere molto più creativi rispetto alla tastiera culturale parziale che può trincerarsi dentro i media e questo proprio grazie alla loro capacità di essere in rete come soggetti strategici perchè anche produttivi (penso non solo ai blog che comunque ancora resistono, ma anche alla produzione video che li rende protagonisti di una comunicazione esplorativa e creativa che sta ai margini del sistema). Ma per dirla con Jobs “i puntini” si possono unire solo guardandosi all’indietro ed è necessario che ci sia qualcuno che continui ad aiutare i giovani a farlo…forse noi abbiamo un po’ troppo delegato in questo processo…sottraendoci ad una delle tante possibilità di accompagnamento del tipo “copia-incolla-integra-rielabora-e tu che ne pensi?”. Forse più che educare a “come sopravvivere alla tempesta” dovremmo cominciare ad educare a “come danzare nella pioggia”…forse mi sono lasciata trascinare anch’io dal fuzzy-pensiero :D…lasciando divagare le mie riflessioni forse un po’ sconnesse ma assolutamente “affamate” e “folli” perchè del resto “l’unico fatto certo è che senza il condimento della follia non può esistere piacere alcuno” (Erasmo da Rotterdam)…perciò grazie per aver suscitato questo ragionamento “folle” nel quale mi sono piacelvolmente avventurata 😉